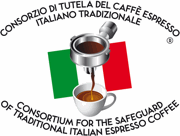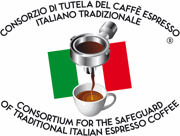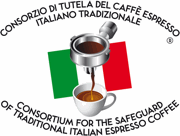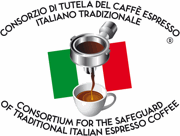La nascita dell’espresso
Per tre secoli, il mondo del caffè ha lavorato sodo per soddisfare tre necessità: rapidità, forza, piacereAl tramonto del XIX secolo il caffè c’era ed era entrato nelle abitudini degli occidentali almeno da tre secoli. Durante questo lasso temporale si erano sviluppati molti sistemi per la sua preparazione, operazione non facile, perché non è solo questione di preparare un infuso, ma di farlo velocemente per poterlo consumare sempre fresco e, nello stesso tempo, di avere il massimo degli elementi pregiati contenuti nel vegetale, lasciando nei residui quanto di meno pregiato il caffè contiene sotto il profilo igienico e sensoriale.
In pratica, per almeno tre secoli, il mondo del caffè ha lavorato sodo per soddisfare tre necessità tra loro fortemente connesse: rapidità, forza, piacere.
La rapidità
Se fosse vero che del caffè apprezziamo soprattutto la caffeina, il sistema più rapido per assumerla dalla pianta sarebbe farsi un’insalata con le foglie o mangiarsi le drupe, crude o bollite, come facevano gli antichi. Con la globalizzazione siamo certi che ci sarebbe chi potrebbe farcele avere fresche sulla tavola tutti i giorni. Ma quasi certamente sarebbero gradite solo ai masochisti del gusto.
La genialità – non sappiamo di chi – fu di tostare i semi, perché non solo attraverso il processo termico assumono l’aroma da noi tutti conosciuto e apprezzato, ma consentono di operare un’estrazione dei costituenti di pregio attraverso quantità di acqua relativamente piccole. Calda o fredda? Il solvente universale agisce comunque, ma aumentano i tempi, quindi, nonostante l’estrazione a freddo sia nota sin dal 1832, va contro la rapidità ed è applicata molto raramente.
Per contro, è facile dedurre che la velocità di estrazione aumenta con la temperatura dell’acqua, quindi portandola in pressione si supera la temperatura di ebollizione migliorando la rapidità e la forza della preparazione. Ma si diminuisce la piacevolezza, quindi l’edonismo, in seguito della maggiore estrazione di sostanze amare e astringenti e la contemporanea perdita degli aromi più eleganti.
La forza
In ben pochi casi negli umani e quasi mai negli animali, la percezione sbaglia nel giudicare gli effetti fisiologici di un alimento, e così è anche nel caso del caffè. Fatto sta che fin dagli albori un caffè giudicato forte sensorialmente era anche percepito come una bevanda capace di manifestare maggiormente i suoi effetti nervini. La forza era – ed è – valutata attraverso tre elementi: l’intensità dell’aroma, la consistenza tattile (il corpo, o sciropposità che dir si voglia) e l’intensità dell’amaro.
Per ottenere un caffè forte occorre agire su tre variabili: la specie (la Canephora – alla quale appartiene la Robusta – dà caffè più forti rispetto all’Arabica), la tostatura e l’estrazione. Va da sè che utilizzando Robusta e tostando scuro si aumenta la forza, ma parimenti si riduce anche la piacevolezza.
Vero è che, agli albori dell’uso del caffè in Europa (siamo nel 1600), la specie in uso era solo l’Arabica, ma doveva essere ben cattiva se una nobile francese di alto lignaggio, ospite dell’ambasciatore del sultano Maometto, ci mise dentro un po’ dello zucchero portato per gli uccellini dell’anfitrione. Ne migliorò così tanto il sapore che – correva l’anno 1669 – da quel momento anche il diplomatico prese a utilizzarlo.
Con lo zucchero non si ha solamente una compensazione psicologica dell’amaro, ma anche una maggiore sciropposità e una maggiore persistenza aromatica, tanto che, come annota Johann Vesling (anatomista e botanico tedesco) nel 1638 in visita al Cairo, in Egitto si usava già e si facevano anche canditi con le bacche del caffè.
Il caffè era comunque un prodotto costoso e quindi si tendeva a sfruttarlo al massimo, non tanto ricorrendo alla tostatura che, stanti i mezzi dell’epoca, veniva come veniva, con non pochi chicchi bruciacchiati, ma con l’estrazione, facendolo bollire anche dieci o dodici volte.
All’inizio infatti il metodo di preparazione era alla turca: il classico pentolino di rame a doppio tronco di cono, si porta l’acqua all’ebollizione, si versa il caffè e rimette sul fuoco. Quando bolle schiuma e rischia di tracimare, per cui si toglie dal fuoco fino al completo spegnimento della schiuma e poi si rimette. Secondo Brillant Savarin non più di tre volte, ma lui oltre che essere un raffinato gourmand era ricco, i poveri facevano ribollire anche i fondi pur di sentire l’aroma di caffè.
L’edonismo
Quando qualcosa fa stare bene il nostro cervello ne registra l’utilità e finisce che ci viene a piacere, anche se non mancano segnali avversi che normalmente deprimono il livello di edonismo. Solo così si può spiegare l’accettazione dell’amaro nella birra, in certi liquori e … nel caffè. Quando però a questo si aggiunge l’astringente (la classica percezione della mucosa orale che si fa rasposa/rugosa, quasi raggrinzisse e si seccasse) l’accettabilità di qualsiasi prodotto scende oltre il livello di guardia.
In passato la specie non costituiva un problema come oggi che la Robusta ha una partecipazione consistente alla produzione mondiale, ma la tostatura approssimata con possibilità di bruciacchiare i chicchi e la ribollitura erano sicuramente temibili per la riduzione del piacere derivante da una tazza di caffè. I fondi poi, se da un canto aumentavano la forza, dall’altra non solo erano (e sono) fastidiosi, ma fanno lievitare l’amaro e l’astringente.
Si lavorò sulla foggia delle caffettiere, su artifizi per farli decantare e su filtri posti sul beccuccio versatore migliorando la qualità in tazza, ma senza risolvere il problema. Il caffè si voleva nero e bollente, soprattutto fresco e non riscaldato, perché tra i problemi che evidenzia c’è pure l’irrancidimento della frazione grassa che contiene, già evidente a pochi giorni dalla tostatura se lasciato all’aria, a poche ore se macinato e a non molti minuti se pronto per la beva.
Fu quindi su questi presupposti che nacque l’espresso italiano e, come vedremo in seguito, costruttori di attrezzature e torrefattori ebbero pari merito nel raggiungimento di un risultato di successo.
Luigi Odello, da L’Assaggio n.57